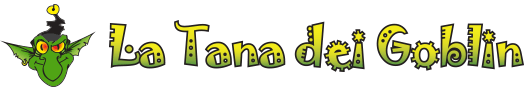Nel panorama del gioco da tavolo moderno innumerevoli titoli propongono, in salse diverse, temi ed ambientazioni legate alla storia e alle leggende irlandesi, o più in generale all’immaginario celtico. Titoli anche molto diversi tra loro sfruttano i temi e le ambientazioni legate all’Irlanda e al suo patrimonio folcloristico.

Tuttavia, la storia del gioco da tavolo in Irlanda è ben più antica. Nonostante il concetto di gioco da tavolo sia presente in una certa misura nella quasi totalità delle civiltà globali, l’Irlanda spicca per le numerosissime testimonianze storiche e letterarie che riguardano la sua diffusione nell’isola.
Evidenze archeologiche hanno dimostrato che il gioco da tavolo ha raggiunto l’Irlanda poco dopo essere sbarcato in Gran Bretagna, già a partire dall’anno 700 d.C. I giochi diffusi erano primariamente varianti locali di due giochi romani: il primo era un gioco di corse basato su meccaniche di lancio dadi e conteggi con abaco; il secondo una versione riambientata del gioco di battaglie ludus latrunculorum. Nonostante si abbiano poche e vaghe notizie su regole e meccaniche, il gioco dei latrunculi (briganti) era giocato su una scacchiera, con pezzi e meccaniche forse non troppo lontani dalla moderna dama.
Se per il gioco dei latrunculi ci sono poche notizie, il suo discendente, il Fidchell, è arrivato fino ai giorni nostri con abbondanza di documenti a riguardo. La natura di gioco di strategia è racchiusa nel suo stesso nome: letteralmente “Il senso del legno”, da fid che appunto significa “legno” (riferito alla tavola di gioco) e cìall, che significa “senso, intelligenza, mente”, ma anche “buon senso, saggezza”.

Come riportato dalle storiche del gioco Katherine Forsyth e Geraldine Parsons, a partire dal IX secolo, vi sono testimonianze della diffusione in Irlanda dell’importazione del norreno hnefltaft o anche chiamato tablut (un’altra variante del ludus latrunculorum, ma con forze asimmetriche), che sembra essere stata ribattezzata localmente con il nome brandub, ovvero “nero corvino”. Il museo nazionale irlandese ne possiede una celebre tavola da gioco del X secolo, ritrovata nei pressi di Ballinderry.
A partire dai secoli successivi, il gioco degli scacchi acquista sempre più popolarità, arrivando infine a soppiantare in larga parte i giochi locali. Il fatto che in Irlanda manchino esempi di sepolture corredate da beni e ricchezze associate alla salma implica che quasi tutte le testimonianze archeologiche relative ai giochi da tavolo consistano in ritrovamenti isolati in contesti domestici, e quindi non chiaramente attribuibili a un sesso piuttosto che all’altro, o tantomeno a uno specifico status o funzione sociale.
Così come nel gioco da tavolo moderno, e nei titoli menzionati in testa all’articolo, le vicende alla base della tematizzazione di giochi più antichi sono ambientate sia in Irlanda sia in aree vicine, come la Scozia, a volte mescolando le due culture e le due mitologie (nel gioco moderno, spesso le ambientazioni celtiche mescolano elementi legati all’Irlanda con altri legati alla Scozia in un unico universo ludico quasi indistinguibile).

Questo tipo di ambientazione era estremamente efficace, dovendo risuonare con le aspettative e le preferenze del pubblico sull’esperienza del gioco, e riflettere ciò che si immaginava come interazione sociale tipica tra i giocatori. Anche quando i personaggi sono descritti come eccezionali per posizione sociale o abilità, è ragionevole ritenere che le scene di gioco in cui compaiono affondino le radici nell’esperienza reale del pubblico rispetto ai giochi evocati.
In altre parole, la presenza del gioco da tavolo in Irlanda, stando alle esperienze e i documenti arrivati sino a noi, non è troppo lontana dal modo in cui il gioco da tavolo moderno viene prodotto ed inteso ai giorni nostri. Malgrado un turnover più rapido e un mercato in larga crescita, che spesso lascia poco spazio all’approfondimento, i giochi si sviluppano intorno a temi o ambientazioni che il pubblico desidera, alcuni più spinti da mode del momento (magari dovute a film di successo, videogiochi o opere letterarie), e altri invece più classici e intramontabili. Oggi così come più di mille anni fa, gli esseri umani cercavano nel gioco da tavolo un’occasione di socialità, tenuta insieme da un’esperienza ludica che richiamasse leggende o storie (o storia vera e propria) che potessero intessere legami emotivi tra il giocatore/giocatrice ed il giocato.
Germanista di formazione, americanista nelle notti d’inverno quando nessuno può spiare dalla finestra.
Ho iniziato con anni di serate davanti a Risiko e tentativi falliti di proporre titoli più esuberanti come Munchkin o Age of Empires III. Ho (ri)scoperto il gioco da tavolo moderno nel 2020, e mai più abbandonato. Tra i miei titoli preferiti spiccano Marco Polo, Scythe, Terra Mystica, La Festa per Odino, Darwin’s Journey e Gloomhaven.
Nel tempo libero mi guadagno da vivere negli Stati Uniti come musicologo, compositore e pianista.